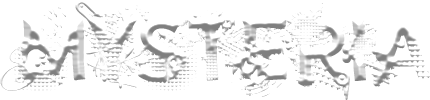Tradizionalmente in passato la Luna era vista come un corpo celeste perfetto, liscio, incorruttibile. Veniva spesso raffigurata così nei dipinti religiosi che rappresentavano soggetti come l’Immacolata concezione o la donna dell’Apocalisse.
Ma tra le tante versioni, un caso interessante è l’affresco commissionato tra il 1610 e il 1612 all’artista toscano Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-1613) da papa Paolo V nella Cappella Paolina della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Ai piedi della figura femminile Cigoli dipingeva una Luna dall’aspetto nuovo per l’epoca, con una superficie irregolare, scabra, costellata di crateri, avvallamenti, montagne.
In altre parole, imperfetta, proprio come la Terra, in linea con quanto andava sostenendo la nascente cosmologia moderna. Galileo Galilei, in primis. La Chiesa, allora, pensava che la luna fosse un corpo puro, liscio, perfetto, senza asperità. Eppure Cigoli non venne censurato: le autorità ecclesiastiche preferirono rimanere prudenti.

Amici di vecchia data
Cigoli si era direttamente ispirato ai bellissimi disegni realizzati in quegli anni da un suo amico di vecchia data, un uomo di scienza dal nome altisonante, Galileo Galilei (1564-1642). I due si conoscevano da quando, a Firenze, studiavano le tecniche della prospettiva, del disegno e del chiaroscuro. Anche se le loro strade professionali si erano divise, a unirli rimanevano due grandi passioni: la scienza e l’arte.
Se da un lato Galileo, amante del disegno, discuteva con Cigoli di pittura e scultura, dall’altro Cigoli, esperto di geometria e matematica, inviava a Galileo i disegni delle sue osservazioni al cannocchiale delle macchie solari, confermando le tesi dell’amico scienziato.
Tocco d’artista
Il volto moderno della Luna apparve per la prima volta la sera del 30 novembre 1609, quando Galileo Galilei, che si trovava a Padova, puntò il suo cannocchiale verso la Luna, notò le irregolarità che la caratterizzavano e realizzò uno schizzo per registrare le sue scoperte.
Nei successivi diciotto giorni, egli tracciò almeno altri cinque disegni, sulla base dei quali preparò degli accuratissimi acquerelli: quattro di questi li scelse da pubblicare come stampe a corredo del suo rivoluzionario Sidereus Nuncius, che comparve nel marzo successivo, destinato a rivoluzionare il modo di guardare l’universo.
In questo trattato Galileo annunciava ad un pubblico meravigliato che la Luna era un ammasso di elementi – un mondo – e non un globo perfetto. Era una nuova terra, che doveva essere esplorata, mappata e battezzata. Era nata la selenografia.
Vi erano illustrate le scoperte fatte grazie al cannocchiale: dai quattro satelliti di Giove alla composizione della Via Lattea, ma soprattutto si potevano ammirare le immagini della superficie lunare, con i crateri e le montagne, le luci e le ombre proiettate dalla Terra nelle varie fasi della Luna.
Per la prima volta grazie al nuovo strumento erano visibili particolari inafferrabili a occhio nudo. Ma l’originalità di Galileo stava anche nella sua capacità di rappresentare con maestria ciò che aveva osservato grazie ai suoi trascorsi in campo artistico. Lo scienziato toscano infatti non era l’unico a scrutare il cielo tra il 1609 e il 1610.

Concorrenza
Anche l’astronomo inglese Thomas Harriot (1560-1621), per esempio, era impegnato a osservare la Luna con un cannocchiale da lui costruito. Sebbene avesse notato che alcune aree apparivano più scure di altre, i suoi disegni erano piuttosto schematici e ben lontani da quelli in chiaroscuro di Galileo, i cui originali sono oggi conservati nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
Grazie all’amicizia con Cigoli, uno dei simboli della nuova scienza faceva il suo ingresso in una basilica papale, pochi anni prima dell’inizio dei guai giudiziari di Galileo con il Sant’Uffizio. L’uomo avrebbe visto da vicino il satellite della Terra e i suoi crateri solo più di tre secoli dopo, con le missioni Apollo della NASA e il programma lunare dell’Agenzia spaziale sovietica.