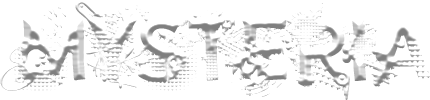Galileo rimase stupito e ammirato, quando si accorse con il suo piccolo cannocchiale che le stelle in cielo erano molte più di quelle che poteva vedere a occhio nudo. Nei quattro secoli trascorsi da allora, lo sviluppo della tecnologia ha reso i telescopi sempre più potenti. Di conseguenza, è aumentata in misura impressionante la quantità di stelle osservabili e la densità dei campi stellari visibili in un’unica immagine.
Nel corso della storia molti miti e leggende sono sorti per spiegare l’origine della Via Lattea: dal latte di Era che allatta Eracle nella mitologia greca al Gange etereo dell’India; immaginata da Democrito e dagli astronomi arabi come una scia di stelle lontane, fu riconosciuta come tale da Galileo Galilei e, in seguito, da studiosi e filosofi come Immanuel Kant, William Herschel e Lord Rosse.
Osservando la Via Lattea dalla Terra, che giace in uno dei suoi bracci di spirale, essa appare nel cielo notturno come una fascia chiara di luce bianca che percorre trasversalmente l’intera volta celeste, dove si addensa un numero di stelle maggiore che nelle altre aree del cielo e che appare di aspetto leggermente diverso a seconda dell’emisfero in cui ci si trova.

Numerose interruzioni nella sua continuità sono causate dalla presenza in più punti di nebulose oscure e polveri che oscurano la luce delle stelle più lontane. Il tratto più luminoso ricade tra le costellazioni di Ofiuco, Scorpione e Sagittario, ossia in direzione del centro galattico; numerosi altri punti brillanti si dispongono a nord e a sud del centro, in particolare il tratto costituito dal Braccio del Cigno, nell’omonima costellazione, e dal Braccio della Carena-Sagittario, nella costellazione della Carena.
I Babilonesi, popolazione mesopotamica assai nota per i giardini pensili e l’astronomia, credevano che la Via Lattea fosse ottenuta dalla metamorfosi della coda della dea-drago Tiāmat, dopo che questa venne catturata dal dio Marduk.
Gli antichi Egizi consideravano la Via Lattea come una controparte celeste del Nilo: un fiume chiaro che attraversava il cielo notturno esattamente come il Nilo attraversava le loro terre.
Aristotele descrisse la Via Lattea in una sua opera sulle scienze della terra, la Meteorologica (340 a.C.), ma già prima di lui i filosofi Anassagora (circa 500-428 a.C.) e Democrito (450-370 a.C.) avanzarono l’idea che la Via Lattea fosse una lunga scia di stelle molto distanti. L’astronomo persiano Abū Rayhān al-Bīrūnī (973-1048 d.C.) fu il primo a notare che la Via Lattea è formata da un insieme di innumerevoli stelle nebulose.
Una prima conferma giunse nel 1610, quando Galileo Galilei usò un cannocchiale per studiare la Via Lattea: vide in effetti che era composta da un elevatissimo numero di deboli stelline. In un trattato del 1755 Immanuel Kant, rifacendosi ad un’opera precedente di Thomas Wright, speculò correttamente che la Via Lattea fosse in realtà un corpo in rotazione formato da un numero enorme di stelle, legate dalla forza di gravità come avviene nel sistema solare, ma in scala molto maggiore; dall’interno il disco di stelle è visto come una lunga scia chiara solo per un effetto prospettico. Speculò inoltre, sempre correttamente, sul fatto che alcune delle nebulose visibili nel cielo notturno non fossero altro che delle galassie simili alla nostra ma molto più lontane.

Il primo tentativo di descrivere la forma della Via Lattea e la posizione del Sole al suo interno fu di William Herschel nel 1785, attraverso un conteggio scrupoloso del numero di stelle in seicento regioni differenti del cielo. Disegnò in seguito un diagramma della forma della Galassia, considerando erroneamente il Sole nei pressi del suo centro.
Nel 1845 Lord Rosse costruì un nuovo telescopio che gli consentì di distinguere la forma ellittica e spiraliforme di alcune delle nebulose allora conosciute; inoltre cercò di capire quale fosse il punto sorgente individuale in molte di queste particolari nebulose, secondo quanto formulato in precedenza da Kant.
Nel 1917 Heber Curtis osservò la supernova S Andromedae all’interno della Grande Nebulosa di Andromeda; cercando poi nei registri fotografici trovò altre undici stelle novae. Curtis determinò che la magnitudine apparente di questi oggetti era stata 10 volte inferiore di quella che raggiungono gli oggetti all’interno della Via Lattea. Come risultato egli calcolò che la nebulosa dovesse trovarsi ad una distanza di circa 150 000 parsec. Diventò così un sostenitore della teoria degli universi isola, che affermava che le nebulose di forma spirale erano in realtà galassie separate simili alla nostra.
Nel 1920 ebbe luogo il Grande Dibattito tra Harlow Shapley e Heber Curtis riguardo alla natura della Via Lattea, delle nebulose spiraliformi e sulle dimensioni dell’Universo. Per supportare l’ipotesi che la Grande Nebulosa di Andromeda fosse in realtà una galassia esterna, Curtis indicò la presenza di linee oscure simili alle nebulose oscure osservabili nella Via Lattea, come anche il notevole Effetto Doppler osservato.

Il problema fu definitivamente risolto nei primi anni venti da Edwin Hubble che si servì del potente telescopio Hooker, appena costruito nell’osservatorio di Monte Wilson. Fu in grado di risolvere le parti esterne di alcune nebulose spiraliformi come insiemi di stelle e identificò alcune variabili Cefeidi, che lo aiutarono a stimare la distanza di queste nebulose: queste si rivelarono troppo distanti per essere parte della Via Lattea. Nel 1936 lo stesso Hubble ideò un sistema di classificazione per le galassie in base alla loro morfologia ancora usato ai nostri giorni, la Sequenza di Hubble.
Definire l’età esatta della Via Lattea presenta notevoli difficoltà; l’età stimata di HD 140283, la stella più antica conosciuta nella Galassia, è di circa 13,6 miliardi di anni, un’età non molto diversa da quella dell’Universo stesso. Questa stima è basata sulle ricerche condotte nel 2004 da un team di astronomi che si servirono dello spettrografo del Very Large Telescope per misurare, per la prima volta, il contenuto in berillio di due stelle dell’ammasso globulare NGC 6397. Da queste ricerche emerse che il lasso di tempo che separa la comparsa della prima generazione di stelle dell’intera Galassia da quella dell’ammasso globulare esaminato si aggira tra i 200 e i 300 milioni di anni.

Le osservazioni condotte dal telescopio spaziale Spitzer nel 2005 confermarono che la Via Lattea è realmente una galassia a spirale barrata: la nostra Galassia è dunque formata da un nucleo centrale (bulge) attraversato da una struttura simile ad una barra, costituita da stelle evolute, circondate da gas e polveri; dalla barra si dipartono quattro strutture a spirale logaritmica su cui si dispongono le formazioni stellari più giovani. La distribuzione della massa nella Galassia sembra ricalcare il modello Sbc suggerito nella classificazione di Hubble, ossia una galassia spirale con dei bracci relativamente sottili e sfrangiati. L’ipotesi che la Via Lattea fosse in realtà una spirale barrata, e non una semplice galassia a spirale come si credeva inizialmente, iniziò ad interessare gli astronomi attorno agli anni ottanta; i loro sospetti furono confermati dalle osservazioni condotte dal telescopio spaziale Spitzer nel corso del 2005.
Dalla combinazione dei dati di Hubble Space Telescope e di Chandra X-ray Observatory, la NASA ha elaborato un video a 360° del centro della Via Lattea.