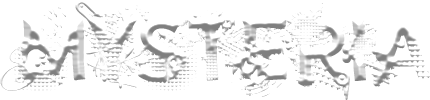L’Isola del diavolo era un piccolo paradiso al largo della Guyana francese che a metà Ottocento si trasformò in un carcere degno di un girone dantesco.
Impossibile uscirne vivi: la famigerata Isola del diavolo (Île du Diable) – insieme alla San Giuseppe (Île Saint-Joseph) e alla Royale (Île Royale) nella Guyana francese, in Sud America – era un buco nero a cui si sfuggiva solo da morti, dopo una serie infinita di umiliazioni.
La colonizzazione della Guyana da parte dei francesi fu un fallimento abissale, in termini di vite perse, negli annali della colonizzazione americana. L’intento della Francia era quello di farla diventare una colonia agraria.
Le cose però, andarono diversamente, 10mila dei 12mila coloni inviati morirono nel giro di due anni di febbre gialla, dissenteria e altre malattie tropicali. Il territorio non era adatto alla coltivazione, tanto meno le coste offrivano porti naturali per il commercio. Un luogo maledetto.
Eppure, paradossalmente, la colonia penale fu istituita a metà Ottocento per riabilitare i detenuti: la risposta illuminata alla barbara pena dei carcerati in catene, così come auspicato dai nuovi valori partoriti dalla rivoluzione francese.
A inaugurare la colonia penale di Cayenne nel 1852 fu Napoleone III. Era riservata ai delinquenti comuni condannati a pene brevi o a detenuti politici. Ma diventò per i malcapitati l’anticamera della morte. I numeri fanno rabbrividire: 10mila i morti solo tra il 1854 e il 1867.
Il penitenziario era costituito da diverse strutture, sia sulla terraferma che sulle tre isole, un famigerato inferno verde dal quale era praticamente impossibile uscire vivi: solo 2.000 degli 80.000 prigionieri condannati ai lavori forzati alla Cayenne riuscì a sopravvivere.
Com’è possibile che l’arcipelago della Guyana (e l’Isola del diavolo in particolare) si sia trasformato in un lager a cielo aperto?
L’Isola del diavolo: buone intenzioni con risultato l’inferno
Se è vero il proverbio di buone intenzioni è lastricato l’inferno, la storia di queste isole sembra esserne la conferma. Sulla carta avrebbero dovuto essere un gioiello, come Mettray, la colonia agricola istituita nel 1840 in Francia e presentata al pubblico come un riuscito esperimento di riabilitazione carceraria.
Qui a ogni detenuto veniva dato un appezzamento di terra da coltivare offrendogli la possibilità di rifarsi una nuova vita, lontano dalle grandi metropoli: vivere a contatto con il verde, e non con i miasmi delle città, era considerato garanzia di salute fisica e soprattutto mentale.
E l’idea non era peregrina, il problema del recupero dei detenuti allora era molto sentito; le grandi città, sempre più urbanizzate, si stavano trasformando in un ricettacolo di piccoli delinquenti, aumentando anno dopo anno le sacche di disagio urbano, luoghi poco sicuri, con spazi insalubri e un sottoproletariato potenzialmente fuori controllo.
Chi commetteva un reato, finiva inevitabilmente in una spirale viziosa che lo portava a reiterarlo, anche dopo aver scontato la pena, infatti, all’aumento dei crimini corrispondeva un alto tasso di recidività: dal 1825 al 1837 la crescita fu del 39%. Chi usciva dalle carceri cittadine restava legato ad ambienti criminali.
Non c’è da stupirsi quindi se si pensò di risolvere il problema alla radice, spostando qualche miglio più in là i soggetti scomodi, confidando che la vita in campagna li redimesse da ogni male.
L’Isola del diavolo: una vita infame
I primi a essere spediti oltreoceano furono proprio i recidivi, quelli che, più di tutti, avevano bisogno di allontanarsi dalla civilizzazione corruttrice. Ma poi vi finirono anche i detenuti politici, come il capitano Alfred Dreyfus, il militare francese ebreo ingiustamente accusato di alto tradimento, che trascorse cinque anni della sua vita (1895-1899) sull’Isola del Diavolo in totale isolamento.
Il viaggio per raggiungere il paradiso si rivelava sempre un’odissea. I detenuti navigavano su piroscafi, stipati come animali, con razioni misere di acqua e di cibo. Arrivati nella giungla dell’America Centrale le cose non potevano che peggiorare.

Chi non si atteneva alle regole e chi tentava la fuga era trasferito nell’isola di Saint-Joseph, soprannominata dai detenuti Mangeuse d’homme, la mangiatrice di uomini.
Qui, i detenuti impazzivano dopo anni trascorsi in isolamento, nel buio più totale, praticamente sepolti vivi dentro celle prive di finestre, e dalla spesse porte di ferro; non potevano parlare nemmeno con le guardie che passavano loro il cibo attraverso le piccole fessure.
Meno fortunati, erano quei prigionieri che venivano calati nelle Fosse dell’Orso, pozzi di cemento coperti da una griglia di ferro: qui i detenuti erano esposti alle intemperie e preda dei pipistrelli vampiro. Molti di loro, con le gambe incatenate ad una sbarra di ferro, venivano lasciati nelle fetide celle dell’isola di Saint-Joseph fino alla morte.

L’Isola del diavolo: fughe rocambolesche
L’unico modo per preservare un po di dignità era accarezzare l’idea di una fuga, impresa quasi impossibile. In tanti ci provarono, pochi ci riuscirono. I galeotti erano sorvegliati da due guardiani infaticabili: il mare e la giungla. L’oceano era infestato da squali e percorso da fortissime correnti, quindi una via di fuga impraticabile.
La giungla era una barriera naturale: insetti letali, animali feroci e agguerrite popolazioni indigene rendevano un azzardo mortale attraversarla. La scelta si riduceva tra morire di malaria, tifo e febbre gialla, o tentare l’evasione sapendo che le possibilità di sopravvivere erano pari a zero.
Chi veniva riacciuffato finiva in isolamento. Nel 1855 l’aspettativa di vita sull’isola era (secondo uno studio dell’epoca) di un anno, sette mesi e sei giorni. Tra il 1852 e il 1854 ci furono 1.721 morti di febbre gialla tra i 6.288 prigionieri. Una cifra enorme rispetto alle morti nelle prigioni urbane, che si attestavano negli stessi anni al 5%.
E quei pochi che riuscirono a scappare?
Henri Charrière
Tra i più fortunati, Henri Charrière, detto Papillon (per via di una farfalla tatuata sul petto) riuscì nella disperata impresa. Nel suo romanzo Papillon, diventato poi negli anni Settanta un celebre film con Steve McQeeen e Dustin Hoffman, raccontò come riuscì a portare a casa la pelle, tuttavia, smentito dalle autorità francesi che sostengono sia scappato da una prigione continentale e non dalla Guyana.
Nel romanzo affermava di essere saltato da una scogliera con due sacchi pieni di noci di cocco come salvagente. E di essere fuggito in Venezuela, dopo essersi nascosto per tre giorni sulla terraferma, grazie all’aiuto di un complice.

Charles De Rudio
Charles De Rudio era un nobile italiano, che negli anni del Risorgimento, si unì alla carboneria e partecipò ad un complotto per assassinare Napoleone III. Dopo essere stati scoperti, i quattro congiurati furono condannati a morte, ma per De Rudio e un altro cospiratore la pena fu commutata in ergastolo; nel 1858 fu deportato, insieme ad altri 200 detenuti, nella colonia penale della Cayenne.
Dopo aver trascorso un po di tempo ai lavori forzati sulla terraferma, De Rudio fu mandato all’Île Royale, da cui riuscì ad evadere nel 1859, al secondo tentativo. Insieme ad altri detenuti, De Rudio riuscì ad impossessarsi della barca di alcuni pescatori, e dopo molte peripezie arrivò nella Guyana britannica.
L’impresa aveva dell’incredibile: i fuggiaschi avevano navigato su un piccolo battello per quasi mille miglia, senza nulla da mangiare né da bere. Considerati come prigionieri politici, furono bene accolti dagli Inglesi. In seguito De Rudio si trasferì negli Stati Uniti, dove si arruolò nell’esercito, continuando a vivere numerose avventure: fu uno dei pochi sopravvissuti della battaglia di Little Big Horn.
Dopo aver trascorso, tra Francia – Italia – Svizzera – Gran Bretagna, dieci anni della sua vita come rivoluzionario, un anno nell’inferno della Cayenne, e circa trenta come soldato dell’esercito degli Stati Uniti, alla fine De Rudio si stabilì a Los Angeles. Dopo essere sopravvissuto a molti inferni, non poteva scegliere un posto migliore per trascorrere gli ultimi anni in paradiso.
René Belbenoit
René Belbenoit, la storia della sua vita ha ispirato ben due film. Il primo, Condemned, del 1929, uscì mentre era ancora in carcere, sei anni prima della sua clamorosa fuga dalla colonia penale francese. Dopo essere divenuto una leggenda per l’evasione dall’Isola del Diavolo, René Belbenoit collaborò come consulente tecnico al secondo film ispirato in parte alla sua vita: Passaggio a Marsiglia, del 1944, interpretato da Humphrey Bogart.
Alla fine della prima guerra mondiale, dopo aver combattuto con onore nell’esercito francese, Belbenoit fu arrestato per furto, e condannato a otto anni di lavori forzati nella Guyana. All’epoca era in vigore la cosiddetta legge del doppiaggio: alla fine della pena ogni detenuto, prima di tornare in Francia, doveva trascorrere un uguale numero di anni sul territorio della Guyana, ma se la condanna superava gli otto anni, era obbligato a rimanervi per tutta la vita.

Belbenoit arrivò nella Guyana francese il 23 giugno 1923, era il detenuto numero 46.635: tanti ne erano fino ad allora arrivati dal 1852, anno di apertura della colonia penale. Le sofferenze patite da Belbenoit durante gli anni trascorsi in Guyana sono raccapriccianti, ma nonostante le malattie, la fame, le torture, non si arrese mai.
Riuscì a scrivere delle memorie che vendette, mentre era ancora detenuto, ad una coppia di giornalisti americani arrivati a visitare la colonia, Robert e Blair Niles. Sulla base di queste memorie, la Niles scrisse una storia romanzata Condemned to Devil’s Island, che poi ispirò il film del 1929.
Dopo quattordici tentativi di evasione, mai riusciti, Belbenoit, nel 1930, arrivò alla fine della sua condanna, ma non poteva comunque lasciare la Guyana Francese. Grazie alla benevolenza del governatore, ebbe il permesso di allontanarsi per un anno, allo scopo di dimostrare di potersi guadagnare da vivere onestamente, e ottenere la libertà permanente.
Dopo aver trascorso un anno a Panama, lavorando come giardiniere, Belbenoit scoprì che il governatore era cambiato, e sarebbe dovuto tornare in Guyana per sempre, ma decise ugualmente di partire per la Francia, voleva o sperava di ottenere giustizia, al suo arrivo però, fu arrestato e rispedito alla colonia penale il 7 ottobre del 1932.
Dopo aver trascorso i successivi due anni in isolamento, gli fu consentito di tornare sulla terraferma come detenuto libero, insieme ad altri cinque compagni di sventura, Belbenoit riuscì ad acquistare una canoa, con la quale presero il mare, diretti verso Trinidad.
Dopo 14 giorni di navigazione, e quasi 700 miglia percorse, gli uomini ormai disperati raggiunsero l’isola, ma non la salvezza: gli Stati Uniti erano la meta finale. Tutti i suoi compagni furono catturati, solo Belbenoit, dopo incredibili avventure, tra cui una permanenza di sette mesi con gli indiani Kuna, alla fine, attraversando Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, riuscì ad imbarcarsi clandestinamente su una nave da carico che lo fece arrivare a Los Angeles l’11 giugno 1937.
Anche qui, nonostante la fama derivata dal racconto delle sue avventure, dovette affrontare non pochi problemi, tra cui una detenzione di 15 mesi, perché risultava essere entrato illegalmente. Solo nel 1956 ottenne la cittadinanza americana.
Nel 1938, pubblicò il suo romanzo-reportage negli Stati Uniti con il titolo di Ghigliottina secca, un best-seller, che divenne il primo seme per far crescere l’indignazione del mondo nei confronti del regime carcerario della Cayenne.
«Quattro giorni a disposizione per imparare il mestiere, chi al quinto non era ancora capace veniva rinchiuso in cella d’isolamento a pane e acqua».
«Nei campi di prigionia nella foresta i guardiani svegliavano i forzati alle 4:30, quando era ancora buio. Distribuiti gli strumenti di lavoro si andava nella giungla».
raccontò il francese René Belbenoit.
I primi giorni, racconta, «i detenuti avevano un solo obiettivo: vendere i propri abiti in cambio di un po di tabacco contrabbandato dai secondini, dopodiché entravano tutti in uno stato di imbarbarimento collettivo».
La vita scorreva tra abusi fisici e morali che ricordano drammaticamente quelli che saranno i campi di lavoro inaugurati dai regimi totalitari del Novecento. Episodi di nonnismo, violenza fisica, abuso sessuale erano all’ordine del giorno. Come i pidocchi, la fame e la miseria.
L’Isola del diavolo: un luogo senza Dio
L’esperimento della colonia d’oltreoceano, lungi dal redimere i detenuti, si rivelò in tutta la sua inefficacia. Il governo francese ci mise quasi 100 anni ad ammetterlo, ma nel 1938 smise di inviare prigionieri e nel 1953 il carcere venne chiuso definitivamente.
Quello che resta oggi oltre ai racconti di Belbenoit e al romanzo di Charrière, ammesso che sia attendibile, sono le vivide rappresentazioni di un altro testimone oculare: Francis Lagrange, falsario detenuto sull’isola dal 1931 al 1949 che illustrò l’inferno vissuto sui muri della prigione e dell’ospedale.
Una volta scontata la pena, guadagnò qualche soldo illustrando la sua tremenda esperienza su cartoline diventate tristemente famose: altra testimonianza del carcere che doveva redimere i colpevoli e si guadagnò il meritato appellativo di luogo senza Dio.