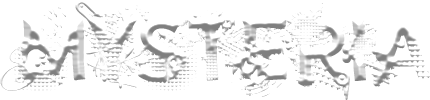Sacri rompiscatole: è l’irriverente stereotipo associato alle figure dei profeti biblici, dipinti spesso come outsider delle logiche mondane, santi uomini chiamati ora a fustigare i costumi di re e popolino, ora a vaticinare pestilenze e calamità come punizione per i loro peccati. Eppure ben pochi furono i profeti emarginati, in rotta con il potere.
Come in altre antiche civiltà orientali, anche nella società ebraica gli intermediari di Dio erano in genere ben introdotti e alleati delle istituzioni. Vicini al potere, ogni decisione del re d’Israele doveva essere preventivamente avallata dalla divinità. Assolvevano questo scopo uno o più profeti dipendenti da una corte, dove per secoli i portavoce della divinità nazionale ebraica, Yahweh, vissero in coabitazione con quelli di concorrenti stranieri dal largo seguito popolare, come il dio fenicio Baal.
Dal primordiale Abramo fino a Mosè (1500 a.C.) e poi per più di un millennio, i profeti rimasero dunque una costante del popolo ebraico. E il loro ascendente tra i contemporanei andava ben oltre le proverbiali grida nel deserto. Dal re i profeti erano consultati sui grandi problemi del momento: come metter fine alla siccità, come trovare acqua durante una spedizione, se e come intraprendere una guerra.
È evidente che l’attività dei profeti aveva grande valenza politica: in nome della divinità potevano incoraggiare il re o frenarlo nell’attività militare, ma anche riprenderlo per comportamenti scorretti pubblici o privati, esacerbare conflitti e persino influenzare le scelte per la successione al trono.
Magico Elia
Ma qual era esattamente l’identikit di questi altoparlanti terreni del sovrannaturale? Chiamati dal loro popolo nabí (proclamatori) oppure hozeh (veggenti), essi non appartenevano a un gruppo sociale definito. A ricevere la vocazione dall’alto, nella Bibbia troviamo di volta in volta pastori come Amos e aristocratici come Isaia, sacerdoti come Geremia e donne come la profetessa Anna.
Inoltre il messaggio profetico poteva essere desunto da visioni, come quelle di Ezechiele, disavventure mirabolanti come quella di Giona (finito nel ventre di un grosso pesce), e a volte anche poteri prodigiosi. È il caso di Elia, forse il profeta più importante di tutto l’Antico Testamento, le cui vicende sono narrate nel I e nel II Libro dei Re. Come per altri personaggi biblici, della sua vita sappiamo pochissimo.
Il nome stesso, Elia, traducibile con il mio Dio è Yahweh, potrebbe essere uno pseudonimo. Secondo la tradizione originario di Tishbe, a est del Giordano, operò all’insegna della lotta all’idolatria: gran parte della sua vita (prima metà dell’VIII secolo a.C.) si svolse sotto il re di Israele Acab, la cui moglie era una fenicia, Gezabele.
Figlia del re di Tiro, la regina aveva introdotto a corte e fortemente sostenuto il culto del dio cananeo Baal e della dea Astarte. A favorire il politeismo c’erano anche condizioni oggettive: più vasto, popoloso e beneficiato dai commerci, il regno ebraico del Nord (l’altro era quello di Giuda) era più aperto agli influssi culturali e religiosi. Insomma, la vicenda di Elia si intrecciò da subito con la politica internazionale del tempo.
Yahweh è stato a lungo una divinità tra le tante, nel senso che i suoi fedeli erano consapevoli dell’esistenza di altri dèi, tutti ugualmente veri. Accadeva anche che alcuni di essi diventassero comprimari di Yahweh, come nel caso della grande madre semitica Asherah. Tante fedi, dunque, spesso in conflitto tra loro: una situazione che la Bibbia semplifica e riassume nell’unico, epico match tra il dio ebraico e Baal. E qui Elia mise in campo tutto il suo prestigio.
La sfida con Baal
A dividere le due religioni c’era tutto: aniconico – cioè non vincolato al culto delle immagini – quello di Yahweh, legato alla fertilità e dunque a immorali cerimonie a sfondo sessuale, spesso con contorno di bevande inebrianti, quello del dio cananeo. Certamente, a corte c’erano profeti di entrambe le divinità, tra loro rivali.
A Elia il compito di sparigliare le carte annunciando ad Acab, seguace di un culto straniero, tre anni di siccità: un affondo diretto alle prerogative di Baal, considerato il numero uno in materia di pioggia, tuoni e fulmini. Sempre per ispirazione divina il profeta si ritirò nei pressi del torrente Cherit dove avvenne il primo prodigio, con stormi di corvi servizievoli che lo rifocillarono.
Quando il corso d’acqua si seccò, guidato ancora una volta dall’alto, Elia si spostò a Zarepta, in terra fenicia, dove trovò alloggio presso una vedova. Qui (anticipando alcuni celebri miracoli del Vangelo) moltiplicò il poco cibo presente nella dispensa dell’ospite e addirittura resuscitò il figlio di lei, deceduto in seguito a una malattia.
Elia tornò da re Acab con la fine della siccità, per risolvere una volta per tutte la questione con la divinità usurpatrice: secondo il racconto biblico, 450 falsi profeti, insieme a una folta rappresentanza del popolo di Israele, furono convocati sul monte Carmelo, nell’Alta Galilea, dove Elia risiedeva in una frugale grotta e dove ebbe luogo la sfida conclusiva con gli avversari.
Massacro
Furono eretti due altari con una pira di legno, sulla quale furono posti due buoi macellati: chi fosse riuscito a invocare dal cielo il fuoco per il sacrificio sarebbe stato dichiarato vincitore. I sacerdoti di Baal, che per dar forza alle suppliche arrivarono a incidersi il corpo con spade e lance (una pratica diffusa in molte società tradizionali), invocarono invano il loro dio per un’intera giornata, incalzati dai commenti ironici del rivale: «Gridate più forte… Forse è distratto, o indaffarato, o magari in viaggio», li sbeffeggiava Elia.
Quando fu il suo turno, a scopo dimostrativo, volle strafare e decise di far bagnare la legna; quindi si raccolse in preghiera e ottenne dal cielo il fuoco del Signore, che incenerì l’altare. Seguì la strage degli sconfitti, che su ordine del poco misericordioso profeta furono sgozzati in massa presso il torrente Kison. Certo, immischiarsi nella politica (o nella religione, che a quel tempo era lo stesso) aveva i suoi rischi. Inseguito dall’ira della regina Gezabele, Elia fuggì a Bersabea, nel regno di Giuda.
E da lì nel deserto dove, scoraggiato dalle incomprensioni, invocò la morte. Arrivò invece il sonno, da cui lo destò un angelo che lo nutrì e lo invitò a dirigersi verso l’Oreb (sul Sinai), dove Mosè aveva ricevuto i dieci comandamenti. Arrivato lì, si rifugiò in una caverna.
Sul carro di fuoco
Ma il ruolo politico di Elia non era esaurito del tutto. Nella narrazione biblica si trovano ancora l’incontro con Eliseo, suo successore nonché capo di una confraternita di 50 fratelli-profeti, e il confronto finale con la schiatta di Acab. Elia infatti profetizza morte e rovina alla regina Gezabele, e anche al figlio della coppia reale, Acazia. La sua colpa, essersi compromesso consultando gli oracoli di Baal.
Acab tentò di far arrestare quel profeta troppo invadente, ma questi distrusse con folgori divine i suoi soldati. Dopo l’ennesimo miracolo (Elia divise in due col suo mantello le acque del Giordano per permettere a lui e a Eliseo di passare), la vicenda del profeta si avviò alla sua pirotecnica conclusione: un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separarono l’uno dall’altro, ed Elia salì al cielo in un turbine.
Prima di lui, solo l’antidiluviano patriarca Enoch era stato sottratto alla morte fisica grazie a un rapimento in cielo, soluzione in cui alcuni studiosi hanno ravvisato la trasformazione di antiche divinità solari in personaggi biblici.
Onnipresente
L’influenza di Elia fu anche postuma, e trasversale. Chi mise per iscritto nella forma definitiva la sua storia, intorno al VI secolo a.C., fece di Elia anche un profeta dell’identità ebraica.
Dalla Bibbia la sua figura passò al Nuovo Testamento (Elia anticipa, anche nel look da predicatore, Giovanni Battista, ma soprattutto appare con Mosè nell’episodio della Trasfigurazione di Gesù). La Chiesa cattolica lo venera come santo e lo considera l’archetipo del monaco. Persino l’islam lo onora come profeta. Quanto alla tradizione giudaica, Elia periodicamente appare in questo mondo per aiutare il suo popolo.
Da questa convinzione ebbero origine consuetudini come la sedia di Elia, lasciata libera per il profeta quale testimone invisibile durante il Brit Milah, la cerimonia di circoncisione dei fanciulli ebrei. La Cabala, infine, lo annovera tra le schiere celesti quale manifestazione dell’arcangelo Sandalfon, incaricato di sovrintendere al movimento nei regni inferiori della materia. Degna conclusione di una carriera tutta in ascesa.