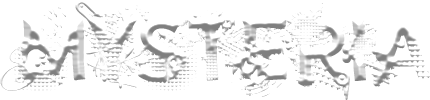Il Convento dei Cappuccini a Palermo è conosciuto in tutto il mondo per la presenza nei suoi sotterranei di un vasto cimitero, che attira la curiosità di numerosi turisti.
Lo spettacolo macabro degli innumerevoli cadaveri esposti è spunto di riflessione sulla caducità della vita, sulle vanità terrene e sull’inutilità dell’attaccamento degli uomini alle loro fattezze esteriori. Appena entrati all’interno delle Catacombe dei Cappuccini, l’impressione è quella di trovarsi di fronte a un gigantesco exercitus mortuorum, una spaventosa armata di revenant.
Il convento dei Cappuccini a Palermo, nel quartiere Cuba, è annesso alla chiesa di Santa Maria della Pace. Chiesa e convento risalgono al XVI secolo, benché edificati su strutture precedenti.
Le gallerie furono scavate alla fine del ‘500 in stile gotico. Non sono mai state inventariate le salme presenti, ma si è calcolato che debbano raggiungere la cifra di circa 8.000.

Le mummie
Le mummie, in piedi o coricate, vestite di tutto punto, sono divise per sesso e categoria sociale, anche se la maggior parte di esse appartengono ai ceti alti, poiché il processo di imbalsamazione era costoso.
Nei vari settori si riconoscono: prelati; commercianti e borghesi nei loro vestiti della domenica; ufficiali dell’esercito in uniforme di gala; giovani donne vergini, decedute prima di potersi maritare, vestite con il loro abito da sposa; gruppi familiari disposti in piedi su alte mensole, delimitate da sottili ringhiere simili a balconate; bambini; ecc.

Se in un ossario i morti sono tutti identici, il processo di mummificazione ha invece la virtù di rendere ogni corpo diverso dall’altro, di conferire ai resti una spiccata personalità – effetto ulteriormente amplificato quando la mummia indossa gli abiti che sfoggiava in vita.
Numerose salme appartengono comunque a frati dell’ordine dei Cappuccini stessi: il primo a essere stato inumato all’interno delle catacombe fu infatti frate Silvestro da Gubbio il 16 ottobre del 1599.
La mummificazione
Le mummie siciliane sono il risultato di un particolare trattamento, senza eviscerazione, ottenuto per essiccamento del corpo in condizioni microclimatiche favorevoli. Il processo di mummificazione in Sicilia, in genere, prevedeva che il cadavere venisse posto in una stanza ventilata, prevedeva prima di tutto di far scolare la salma per circa un anno, dopo averle tolti gli organi interni.
Quindi il corpo, più o meno rinsecchito, veniva lavato con aceto, riempito di paglia, e rivestito con i suoi abiti. Altri metodi, utilizzati specialmente in periodi di epidemie, prevedevano un bagno di arsenico o di acqua di calce.
Un cadavere lavorato con cura dai frati, secondo un procedimento affinato nel tempo. Uno dei termini tecnici che gli antropologi usano per indicare il trattamento di scolatura e mummificazione delle salme è tanatometamorfosi, che rende bene l’idea della vera e propria trasformazione strutturale a cui viene sottoposto il corpo.
La mummia di Rosalia Lombardo

Tra le salme delle Catacombe dei Cappuccini è particolarmente nota quella di Rosalia Lombardo, visibile nella Cappella di Santa Rosalia.
Nata a Palermo il 13 dicembre 1918 e ivi morta di polmonite il 6 dicembre 1920, la bambina è stata una delle ultime persone a essere ammesse alla sepoltura nella cripta. L’imbalsamazione, fortemente voluta dal padre affranto, fu curata dal professor Alfredo Salafia, lo stesso che imbalsamò Francesco Crispi.
Come si è scoperto solo nel 2009 grazie a studi compiuti sugli appunti di Salafia, per l’operazione fu utilizzata una miscela composta da formalina, per uccidere i batteri, alcool, che avrebbe contribuito alla disidratazione, glicerina, per impedire l’eccessivo inaridimento, acido salicilico, che avrebbe impedito la crescita dei funghi e sali di zinco, che conferiscono rigidità.
La bambina appare intatta (infatti attraverso una radiografia accurata si può notare che anche l’intero corpo della piccola è perfettamente integro, si possono vedere chiaramente sia l’emisfero cerebrale e l’organo del fegato) tanto da destare l’impressione che stia dormendo, e da meritare il soprannome di Bella addormentata.
Nonostante il processo di mummificazione sia uno dei migliori, se non il migliore, il corpo presenta piccoli segni di decomposizione. È stato quindi necessario collocare la storica bara all’interno di una teca ermetica di acciaio e vetro, satura di azoto, che impedisce la crescita di microrganismi, tenuta alla temperatura costante di 20 °C e con umidità del 65%.
La mummia di Antonio Prestigiacomo
Una delle mummia più inquietanti è quella di Antonio Prestigiacomo, morto nel 1844 all’età di 50 anni e imbalsamato con arsenico per via endovasale.

A metà ‘800, le disposizioni sanitarie vietarono le sepolture nelle chiese e nelle catacombe, fu eretto a fianco della chiesa il Cimitero dei Cappuccini.